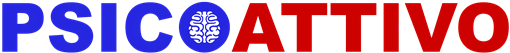La dipendenza intesa come malattia è considerata una forma di progresso etico nella concettualizzazione del consumo problematico delle sostanze o di un comportamento (ad esempio il gioco d’azzardo). Si sostiene cioè che il modello biomedico ha permesso il superamento dello stigma implicito nel modello etico della dipendenza vista come un vizio, una debolezza di volontà, una manifestazione di smodatezza, impulsività e intemperanza (ad esempio Brickman, Rabinovitz, Karuza & Coates, 1982[i]). L’enfasi sulle cause biologiche e sui determinismi patologici delle dipendenze rimuove infatti la responsabilità delle azioni di un individuo, perché queste sono sintomi di una malattia e quindi manifestazioni su cui la persona non può avere il controllo volontario[ii]. Così, il modello biomedico della dipendenza permette di vedere il consumo compulsivo come l’espressione di una dinamica fisiopatologica indipendente dalla volontà. Vale a dire che una persona con una dipendenza non può controllare l’uso della sostanza allo stesso modo in cui un soggetto che soffre di schizofrenia non può governare e regolare volontariamente le allucinazioni o le voci che sente.
Effetti psicologici, sociali e politici dello stigma e del pregiudizio nelle dipendenze

Le credenze sulla responsabilità e l’autocontrollo hanno un ruolo centrale nei processi di stigmatizzazione delle persone con dipendenze. E purtroppo lo stigma e il pregiudizio che accompagnano le dipendenze aggravano la difficoltà che un soggetto dipendente vive. Lo stigma rende più difficili i rapporti con gli altri, la ricerca e il mantenimento di un lavoro, aumenta il senso di vergogna personale e quindi può ostacolare la richiesta di aiuto e l’accesso ai servizi di cura. Lo stigma si riflette anche sulle decisioni politiche. Le forze politiche e i governi, come sembra accadere in questo periodo, possono cavalcare i pregiudizi e gli atteggiamenti stigmatizzanti purtroppo diffusi a livello sociale per accrescere e mantenere il consenso e ridurre i fondi, l’appoggio ai servizi pubblici per le dipendenze, oppure inasprire gli indirizzi repressivi, le sanzioni contro l’uso. Sono soluzioni da sempre usate e che hanno ampiamente dimostrato non solo la loro inefficacia ma che sono state accompagnate da una costante crescita del consumo e dell’uso problematico, dall’abbassamento dell’età del primo approccio alle sostanze e al loro abuso.
La distanza tra conoscenze scientifiche e opinione pubblica sul tema delle dipendenze
La comunità scientifica sembra finalmente essersi liberata della sterile contrapposizione tra natura e cultura. Gran parte delle teorie scientifiche più accreditate considera la dipendenza un fenomeno complesso allo stesso tempo biologico, psicologico e sociale[iii]. Quello che invece sembra non funzionare è il modo in cui la ricerca scientifica sulla dipendenza viene comunicata, che è ciò che purtroppo condiziona prima di ogni altra l’opinione pubblica e quindi la maniera in cui la società si rapporta con le persone che sviluppano un problema con le sostanze o comportamenti compulsivi. Gli studi fatti sulla comunicazione della scienza sembrano infatti testimoniare che le nozioni biomediche continuano a essere diffuse attraverso interpretazioni semplicistiche e datate. Ad esempio, parlando del DNA, i mass media continuano ad abusare della metafora del codice, del programma inteso come set di istruzioni per costruire un organismo, suggerendo l’idea che esista una direzione lineare e deterministica dai geni ai vari tratti biologici di un individuo, come il colore degli occhi, l’altezza, la vulnerabilità verso una malattia[iv].
La comunicazione scientifica sulle funzioni psicologiche e sui meccanismi biologici correlati ai comportamenti è evidentemente ancora più problematica. L’approccio prevalente, quanto banalizzante, sembra essere una forma di neuromania, un fuorviante neuroessenzialismo e indica nel cervello l’organo della mente, la struttura anatomica e funzionale da cui esclusivamente dipendono emozioni, scelte, memoria, comportamenti, disturbi psichiatrici, come le dipendenze[v]. Purtroppo sembra, come ha scritto Dorothy Nelkin, che il modo in cui l’opinione pubblica percepisce e interpreta costi e benefici sociali delle spiegazioni e delle applicazioni scientifiche è influenzato soprattutto dai messaggi dei media piuttosto che dai dettagli dell’evidenza scientifica[vi]. Il fascino seduttivo delle scienza biomediche e delle neuroscienze sull’opinione pubblica finisce di conseguenza per produrre effetti parziali e distorti (si veda anche questo post). È ovviamente comprensibile che sia così. La sempre più elevata complessità e specializzazione della ricerca rende impervia, di fatto impossibile, una reale e specifica comprensione della conoscenza scientifica da parte dei cittadini. Per questa ragione dovrebbe essere imperativo cercare di promuovere una comunicazione più attenta e critica, più aggiornata. Ciò sembra valere soprattutto la comunicazione e la percezione pubblica dell’idea di dipendenza come malattia del cervello, a causa delle straordinarie implicazioni etiche, politiche e sociali che hanno questi comportamenti.
Come abbiamo visto all’inizio del post, si dice che l’idea di dipendenza come malattia sia preferibile a quella di dipendenza come debolezza di volontà perché rimuove lo stigma, il pregiudizio verso i soggetti dipendenti, che diventano malati, non più viziosi, quindi non responsabili dei loro comportamenti d’uso. Ma è proprio così?
A livello pubblico le rappresentazioni biomediche delle dipendenze veicolano stigma e pregiudizio
Gli studi sembrano suggerire che le visioni biologiche dei disturbi del comportamento possono essere più stigmatizzanti e anche meno utili di quanto inizialmente previsto a livello sociale e anche clinico, per l’efficacia del trattamento del paziente e anche nella prevenzione[vii]. Alcune ricerche, inclusa una recente revisione, hanno addirittura dimostrato un aumento della stigmatizzazione nei confronti di individui con malattia mentale quando sono adottate spiegazioni ti tipo biologico[viii].
Così, riformulare la dipendenza come una malattia finisce per evocare stigma ed emarginazione come la vecchia concezione morale[ix], perché sposta semplicemente il pregiudizio e la condanna su altri piani. Lo stigma viene trasferito dalla volontà di chi usa a qualche anomalia nel cervello, che a sua volta sembra implicare un difetto genetico. In questo processo di dislocazione peraltro si realizza anche un percorso di disumanizzazione. Nella concezione etica della dipendenza la colpa viene attribuita alla cattiva volontà di un individuo, che in quanto portatore di autonomia e responsabilità (seppure usate male – ritiene l’opinione pubblica) resta a tutti gli effetti simile alle altre persone, in grado di scegliere, e quindi potenzialmente “redimibile”. Nella cattiva vulgata della concezione biomedica, la tara biologica impone ai soggetti dipendenti un segno di diversità ontologica, qualcosa di più misterioso e inquietante dell’intemperanza e della debolezza della volontà verso il piacere, l’alterazione degli stati di coscienza, verso il bisogno di evasione e di anestesia del disagio. Questi sono aspetti del repertorio dei comportamenti resi comprensibili e quindi “umani”, sia pure in modo pregiudizievole, da codici e strumenti interpretativi ormai millenari. Nella visione biomedica recepita a livello pubblico invece, i difetti cronici del cervello e i geni difettosi che lo hanno costruito rendono un soggetto dipendente qualcosa di diverso e alieno. Un individuo che, come sembra suggerire l’immagine pubblica della biologia delle dipendenze, perde per sempre la sua autonomia, la responsabilità e il controllo dei suoi comportamenti. Ma se un individuo non dispone dell’autocontrollo, non può più recuperare la sua responsabilità, le sue capacità di autoregolazione, allora non è – e non sarà mai – in grado di condividere regole e obblighi verso gli altri membri della comunità in cui vive. Così non può che esser visto come un pericolo e una minaccia, va per questo emarginato, non può essere integrato nel corpo sociale.
L’idea che la malattia cerebrale della dipendenza sia qualcosa di geneticamente determinato e da cui non si guarisce mai veramente condiziona le aspettative e le credenze di chi ne soffre (si veda questo post sul tema), di chi li cura, della pubblica opinione sulla possibilità di recuperare i malati e di fare prevenzione delle dipendenze. E se prevale l’idea che è impossibile prevenire le dipendenze, curare chi ha sviluppato una dedizione patologica a una sostanza o a un comportamento allora per i decisori politici diventa opportuno e conveniente ridurre i presidi e i servizi per fare prevenzione, trattare le dipendenze. La soluzione più coerente e funzionale sembra allora quella più vecchia, inutile e dannosa: reprimere e punire. Che paradossale parabola pratica per una concezione che si è affermata perché doveva servire a rimuovere lo stigma. D’altra parte sembra difficile immaginarsi tra i cittadini reazioni diversi dal pregiudizio quando la scienza descrive e spiega fenomeni che hanno una congrua implicazione morale, come nelle dipendenze, considerati la distanza, la svalutazione e il sospetto verso la conoscenza scientifica che prevale oggi nell’opinione pubblica.
Nel Mulino sulla Floss (1860), George Eliot scriveva:
“I pregiudizi costituiscono il naturale nutrimento delle tendenze, che in certe menti non riescono a sostenersi in quella forma complessa, frammentaria e dubbiosa del sapere che chiamiamo verità. Che un pregiudizio sia trasmesso per eredità, o respirato nell’aria, o adottato per tradizione, o raccolto con gli occhi, comunque possa esser venuto, quelle menti gli daranno ospitalità: esso è qualcosa che si può affermare con energia e coraggio, qualcosa che può supplire all’assenza di opinioni spontanee, qualcosa da imporre agli altri con l’autorità di un diritto consapevole; è un legno che allo stesso tempo fa da metro, stampella, randello e bastone del comando”.
Stefano Canali
Riferimenti bibliografici
[i] Brickman, P., Rabinovitz, V. C., Karuza, J., & Coates, D. (1982). Models of helping and coping. American Psychologist, 37, 368–384
[ii] Hyman, S.E. 2007. The neurobiology of addiction: Implications for voluntary control of behavior. The American Journal of Bioethics 7: 8–11.
[iii] Carter, A., and W. Hall. 2012. Addiction neuroethics: The promises and perils of neuroscience research on addiction. Cambridge: Cambridge University Press
[iv] Condit, C.M., and D.M. Condit. 2001. Blueprints and recipes: Gendered metaphors for genetic medicine. Journal of Medical Humanities 22: 29–39.
[v] Si vedano ad esempio: Roskies, A. 2002. Neuroethics for the new millenium. Neuron 35: 21–23. 19. Racine, E., O. Bar-Ilan, and J. Illes. 2005. fMRI in the public eye. Nature Reviews Neuroscience 6: 159–164. 20. Racine, E., S. Waldman, J. Rosenberg, and J. Illes. 2010. Contemporary neuroscience in the media. Social Science and Medicine 71: 725–733.
[vi] Nelkin, D. 2001. Beyond risk: Reporting about genetics in the post-asilomar press. Perspectives in Biology and Medicine 44: 199–207.
[vii] . Lam, D.C.K., P.M. Salkovskis, and H.M.C. Warwick. 2005. An experimental investigation of the impact of biological versus psychological explanations of the cause of “mental illness”. Journal of Mental Health Administration 14: 453– 464. Angermeyer, M.C., A. Holzinger, M.G. Carta, and G. Schomerus. 2011. Biogenetic explanations and public acceptance of mental illness: Systematic review of population studies. British Journal of Psychiatry 199: 367–372.
[viii] Angermeyer, M.C., A. Holzinger, M.G. Carta, and G. Schomerus. 2011. Biogenetic explanations and public acceptance of mental illness: Systematic review of population studies. British Journal of Psychiatry 199: 367–372. 29. Pescosolido, B.A., J.K. Martin, J.S. Long, T.R. Medina, J.C. Phelan, and B.G. Link. 2010. “A disease like any other”? A decade of change in public reactions to schizophrenia, depression, and alcohol dependence. American Journal of Psychiatry 167: 1321–1330. . Read, J., and N. Harré. 2001. The role of biological and genetic causal beliefs in the stigmatisation of “mental patients”. Journal of Mental Health 10: 223–235. Walker, I., and J. Read. 2002. The differential effectiveness of psychosocial and biogenetic causal explanations in reducing negative attitudes toward “mental illness”. Psychiatry 65: 313–325.
[ix] Hammer, R., M. Dingel, J. Ostergren, B. Partridge, J. McCormick, and B.A. Koenig. 2013. Addiction: Current criticism of the brain disease paradigm. The American Journal of Bioethics Neuroscience 4: 27–32