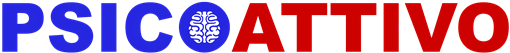L’uso di sostanze psicoattive, compreso il consumo pesante e talora problematico, la dipendenza, ha accompagnato tutta la storia delle diverse civiltà umane, tanto che le tecniche e le sostanze per la modulazione degli stati di umore e di coscienza sembrano costituire un tratto caratterizzante della specie umana. L’antropologo Donald E. Brown ha posto l’impulso alla modificazione degli stati psicologici tra gli “universali umani”, gli elementi, le caratteristiche e le istituzioni comuni a tutte le culture umane e a suo parere unicamente umane, tra cui l’etica, la cosmologia, le arti, la religione, il linguaggio, la legge, la medicina, la gestione del fuoco e la cottura dei cibi, il concetto di anima, le restrizioni sessuali, il tabù dell’incesto e così via (Brown, 1991)[1].
Sino alla fine del Settecento, l’uso – anche abituale e elevato – di agenti psicoattivi, come l’oppio o l’alcol, era generalmente accettato e considerato nella norma. Entrambi sin dall’epoca classica erano peraltro usati23 in ambito medico per una serie sterminata di affezioni e il vino o la birra spesso scelte come bevande d’elezione, considerata la difficoltà a ottenere, conservare e trasportare l’acqua mantenendone la potabilità. Le bevanda alcoliche erano parte essenziale del vitto e delle razioni fornite agli eserciti di tutti gli stati, così come ai lavoratori nelle manifatture e nel settore agricolo. Sino all’Ottocento, nelle città europee e poi in quelle nordamericane le taverne e le osterie hanno rappresentato l’unico e più importante centro di aggregazione sociale e anche di discussione politica.

Engraving by T. Cook, c. 1798, after W. Hogarth.
da Wellcome Images, sito web del Wellcome Trust
L’ubriachezza periodica e abituale erano comuni non sembravano costituire motivo di preoccupazione o allarme sociale. Nel 1772, il giovane Benjamin Rush, che sarà poi padre della psichiatria americana e principale sostenitore dell’idea di alcolismo come malattia, pubblicava il Sermone “On the use and abuse of wine and strong drink” in cui notava quanto fosse accettabile e comune l’ubriachezza ed esaminava le ragioni di alcuni ricorrenti timori[2]. Pur richiamando alcuni temi cari agli ideali della temperanza, indicativamente, il sermone si apriva con una citazione della Bibbia, Proverbi, xxxi. 6, 7. che esaltava le virtù delle bevande alcoliche:
“Date la bevanda inebriante a chi sta per perire e il vino a quelli che hanno l’anima amareggiata.
Beva e dimentichi la sua povertà, e non ricordi più il suo proprio affanno”
Il sermone si apriva infatti con un preciso esame dei molti casi di utilità delle bevande alcoliche, per la dieta di talune popolazioni o per le necessità di individui in determinate condizioni, come i malati cronici o gli anziani. Anche l’uso eccessivo di alcol e talora l’ubriachezza durante le feste o le occasioni sociali erano secondo Rush comportamenti accettabili a patto che non venissero ripetuti di frequente.
Certamente, richiami più preoccupati erano stati già formulati prima di Rush ma rimanevano tutto sommato isolati e soprattutto scarsamente ascoltati e approfonditi. Esisteva inoltre una importante differenza rispetto al modo in cui noi oggi concettualizziamo il rapporto problematico con l’alcol e la dipendenza. Dipendente veniva riferita a un individuo che aveva sviluppato l’abitudine al consumo eccessivo di una sostanza, alcol, oppio: l’abitudine all’ubriachezza o alla condizione stupefatta, non l’abitudine alla sostanza. L’abitudine all’alcol e all’oppio era di molti e tra questi solo pochi sviluppavano l’abitudine alla condizione di inebrietà. L’abitudine a un tipo di comportamento, inoltre, è qualcosa legato a singole scelte, a un modo di vivere sostanzialmente deliberato, non uno schema di comportamento fuori dalla sfera di controllo della volontà, plasmato e innescato dalla mera azione chimica della sostanza.
Dal punto di vista del comportamento osservato non vi è nessuna sostanziale differenza tra l’idea contemporanea di alcolismo e quella moderna, preottocentesca, di inebrietà, ebbrezza. Entrambi infatti rappresentavano soltanto un modo garbato per indicare l’ubriachezza abituale. Esiste però una profonda diversità nel modo in cui questo comune schema comportamentale veniva spiegato dai due differenti riferimenti concettuali. Dal finire del Settecento e soprattutto dagli inizi del Diciannovesimo secolo gli eccessi e la dedizione abituale alle bevande alcoliche iniziò ad essere associata alla presenza di un desiderio irresistibile, di un insopprimibile e incontrollabile bisogno di bere. Questa connotazione, che poneva in questione la volontà e la capacità di scegliere e regolare il rapporto con l’alcol, era totalmente assente nelle rappresentazioni precedenti dell’ubriachezza abituale. Sino ai primi dell’Ottocento, l’ebbrezza abituale era stata sempre vista come la conseguenza di una predilezione individuale, di un desiderio coscientemente assecondato per l’alcol. Nella definizione di alcolismo che si origina circa due secoli fa l’alcolista non ama l’alcol e l’ubriachezza, non sceglie di bere, ma è costretto, perché ha perso il controllo sul bere. Potrebbe addirittura arrivare a odiare l’alcol o cercare consapevolmente di regolare il bere o astenersi, ma non può più riuscirsi perché la sua volontà è stata compromessa dall’azione dell’alcol stesso. In questo caso siamo nella dimensione della patologia quindi, fuori dall’orizzonte morale. Al contrario, nella visione tradizionale, ancora oggi piuttosto diffusa nella percezione comune, l’ubriachezza abituale è un vizio, l’espressione di una passione lucida per l’eccesso, l’effetto di una scelta personale. La responsabilità in tal caso ricade sul soggetto che beve sino a ubriacarsi regolarmente ed è così un comportamento interamente inscritto nella dimensione etica e per questo regolato da norme che dettavano la forma e la forza dello stigma e della sanzione ma anche, e più spesso, la natura e la misura della sua accettabilità sociale. Già perché la figura dell’ubriacone era largamente tollerata nell’era preindustriale. La sua presenza, come quella di altre devianze sociali, era ritenuta tollerabile e inevitabile, espressione imprescindibile della natura umana e delle sue debolezze.
Inoltre, in età moderna, nella prospettiva etica ingenua, quindi la più diffusa, una scelta è sempre in accordo con un desiderio. Così, non si potrebbe volere niente di diverso da ciò che si desidera perché ciò significherebbe per un individuo avere nello stesso momento due istanze opposte della volontà. E allora, un ubriacone abituale vuole e agisce in accordo al suo desiderio di bere, perché ama bere.
È verso la fine del Settecento che questa concezione dell’ubriachezza abituale inizia a prendere la forma dell’idea di alcolismo, quindi di dipendenza, che oggi conosciamo. Ma per quali ragioni emerge questa idea, perché il concetto di intossicazione cronica finisce per perdere la sua connotazione morale e perché proprio in quel periodo storico?
Come ha sostenuto Harry Levine, “l’invenzione del concetto di dipendenza […] può essere meglio compreso non come una scoperta medico-scientifica ma in quanto parte di una trasformazione culturale radicata in alcuni fondamentali cambiamenti nella vita sociale e nella struttura della società”[3].
La trasformazione dell’idea di intossicazione, ubriachezza abituale nell’idea di di dipendenza è fondamentalmente collegata all’emergere alla rivoluzione industriale all’avvento del liberalismo e dei governi liberali nell’Ottocento. È una metamorfosi nel pensiero sociale, piuttosto che un mutamento teorico in medicina. Un mutamento promosso da due distinti da correlati fattori. In primo luogo, la nuova concezione del rapporto dell’uomo col lavoro, l’idea del carattere strumentale del comportamento, come mezzo teso soprattutto alla produzione e al consumo di beni. Un’idea del comportamento peraltro intimamente connessa a quella di un ordine statuale meno tollerante rispetto alla devianza, soprattutto se impattante sulla produzione e a una concezione di organizzazione del lavoro e della vita individuale e sociale necessariamente meglio disciplinata.
In secondo luogo, l’enfasi che il liberalismo e i primi governi liberali, danno all’individuo in quanto attore sociale motivato soprattutto da interessi di tipo materiale, come agente all’interno del libero mercato mosso da preferenze razionali, laddove la razionalità è intesa in primo luogo come capacità di individuare e perseguire la massimizzazione di beni economici. Come scriveva ancora Levine:
“La condizione di una società libera, vale a dire libertà di perseguire I propri interessi personali, richiede lo spostamento del controllo della società al controllo dell’individuo” [4]. L’ordine sociale liberale dovrebbe dipendere fondamentalmente dall’autocontrollo degli individui, così come il suo funzionamento material dalla loro libera e razionale tensione verso gli interessi individuali.
Un oppiomane o un alcolista che indulge nell’inebrietà deroga ai meccanismi e alla funzioni della società liberale e industrializata e soprattutto non risponde a questa nuova caratterizzazione della natura umana. Nessun individuo sano, con intatte le sue facoltà mentali, potrebbe manifestare una distanza così grande dai tratti fondamentali della razionalità dell’agire umano. Per questo non può che essere malato. Un oppiomane o un alcolista sono affetti da una malattia che ha compromesso la ragione, la loro capacità di fare scelte razionali e libere. Di conseguenza, il loro comportamento non ricade nella sfera morale perché è di fatto inconcepibile che un uomo possa fare certe scelte così in contrasto coi suoi “veri” interessi. In questo senso, come fa O’Malley, si può descrivere la concezione moderna di dipendenza come una “peculiare afflizione liberale” [5].
Stefano Canali
Vedremo nei prossimi post l’origine e l’evoluzione del concetto di dipendenza come malattia, a partire dal primo modello organicamente articolato, quello esposto nel 1785 da Benjamin Rush nel un pamphlet intitolato Inquiry into the Effects of Ardent Spirits on the Human Mind and Body.
[1] Brown, D.E. 1991. Human universals. New York: McGraw-Hill.
[2] Rush, B. 1772. Sermons to gentlemen upon temperance and exercise. Philadelphia, John Dunlap, 1772.
[3] Levine HG The discovery of addiction. Changing conceptions of habitual drunkenness in America. J Stud Alcohol. 1978 Jan;39(1):143-74, pp. 165–66
[4] Levine, 1978: p. 163
[5] O’Malley, Risk, Uncertainty and Government. Abingdon: Routledge-Cavendish, 2004, p. 155.