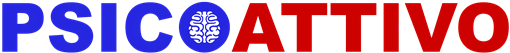Nel 2009, lo psichiatra inglese David Nutt, allora presidente dell’Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), scriveva un editoriale sul Journal of Psychopharmacology dove con toni derisori denunciava l’irrazionale distanza tra i rischi associati alle diverse sostanze psicoattive e il loro status legale (Nutt, 2009)[1]. Il pezzo era scritto in modo paradossale a partire dal titolo: Equasy–An overlooked addiction with implications for the current debate on drug harms, cioè Equasy – una dipendenza sottovalutata con implicazioni per l’attuale dibattito sui danni correlati alle droghe.
Ma in cosa consisterebbe questa sottovalutata forma di dipendenza così ricca di implicazioni per il dibattito sui rischi associati all’uso di sostanze? Equasy è lo stravagante acronimo introdotto da Nutt per indicare la passione per la pratica dell’equitazione: EQuine Addiction SYndrom. Ispirato dall’assonanza linguistica, Nutt comparava i danni dell’ecstasy a quelli dell’equasy.  I dati del sistema sanitario britannico dimostrano che i danni acuti e cronici dovuti all’equasy, sono enormemente maggiori di quelli dovuti all’ecstasy. Ad esempio andando a cavallo c’è un evento di danno acuto a carico di una persona ogni 350 episodi, mentre nel caso dell’ecstasy questo dato è di 1 per ogni 10.000 episodi. A livello della popolazione sono maggiormente diffusi e pù gravi i danni permanenti dovuti a incidenti come cadute da cavallo che quelli collegati all’uso di ecstasy e quindi i costi sociali dell’equitazione sono più elevati di quelli del consumo di questa sostanza. Gli appassionati di equitazione possono soffrire di una sindrome di astinenza, che è controverso esista per l’ecstasy, e così via. Ma allora, si domandava Nutt nell’articolo, perché l’ecstasy è illegale mentre l’equitazione è lecita, anzi dispone di incentivi da parte dello stato, come pratica sportiva e culturale?
I dati del sistema sanitario britannico dimostrano che i danni acuti e cronici dovuti all’equasy, sono enormemente maggiori di quelli dovuti all’ecstasy. Ad esempio andando a cavallo c’è un evento di danno acuto a carico di una persona ogni 350 episodi, mentre nel caso dell’ecstasy questo dato è di 1 per ogni 10.000 episodi. A livello della popolazione sono maggiormente diffusi e pù gravi i danni permanenti dovuti a incidenti come cadute da cavallo che quelli collegati all’uso di ecstasy e quindi i costi sociali dell’equitazione sono più elevati di quelli del consumo di questa sostanza. Gli appassionati di equitazione possono soffrire di una sindrome di astinenza, che è controverso esista per l’ecstasy, e così via. Ma allora, si domandava Nutt nell’articolo, perché l’ecstasy è illegale mentre l’equitazione è lecita, anzi dispone di incentivi da parte dello stato, come pratica sportiva e culturale?
Questo era un ragionamento che avevo già sviluppato in un articolo pubblicato nel 2000 sulla rivista Fuoriluogo, a proposito di quella che allora sembrava un’emergenza ecstasy per via di due casi di morte imputati alla sostanza nel bresciano e nel vicentino. Nei due mesi precedenti, facendo appello agli elementi emotivi, nei toni confusi del sensazionalismo, i mezzi di informazione avevano alimentato un clima di terrore e inferto un duro colpo alla possibilità di discutere in maniera razionale sull’ecstasy, sulla sua diffusione, sulle scelte da adottare per contenere, ridurre o rendere più sicuro il suo consumo. Invitavo per questo a rileggere i dati epidemiologici sulla morbosità e sulla mortalità diffusi dalle statistiche delle organizzazioni della sanità in tutto il mondo. È assolutamente sorprendente confrontare i rischi di morte connessi all’uso dell’ecstasy con quelli correlabili a comportamenti del tutto leciti o ritenuti addirittura salutari. A livello mondiale, probabilmente, le indagini epidemiologiche più estensive sull’uso dell’ecstasy sono quelle condotte in Inghilterra. Useremo, pertanto i dati ottenuti da tali ricerche, anche perché potremmo così raffrontarli con i risultati sui vari rischi di morte nella popolazione inglese pubblicati dalla British Medical Association in un interessante libretto intitolato Living with risk. Secondo il rapporto 1998 dell’Institute for the Study of Drug Dependence (ISDD), punto focale nazionale inglese dell’Osservatorio Europeo sul fenomeno droga, sono 11 le morti da ecstasy, tutte dovute a colpo di calore, registrate in Inghilterra nel 1998. Un dato sostanzialmente stabile dal 1991 quando le statistiche del National Poison Unit riportavano 7 morti da ecstasy. Il numero di persone inglesi che usa l’ecstasy è stimato da uno a tre milioni. Bene, prendendo il dato annuale 1998 della mortalità da ecstasy e assumendo la presenza di un milione di consumatori soltanto (cosa che fa aumentare il tasso di rischio), il rischio annuale di morire per un medio consumatore di ecstasy (25 dosi l’anno) sarebbe di 11 su un milione, cioè 1 su 91.000. Le statistiche elaborate dalla British Medical Association rivelano che questo è un rischio piuttosto basso se lo si confronta con quelli che normalmente si corrono nella vita quotidiana: quali ad esempio fumare 10 sigarette al giorno (1 su 200), fare paracadutismo (1 su 330), cause naturali a quarant’anni (1 su 850), influenza (1 su 5.000), incidenti stradali (1 su 8.000), giocare a calcio (1 su 25.000), incidenti domestici (1 su 26.000). La pubblicazione della British Medical Association rimarca inoltre che il Paracetamolo, una molecola usata come farmaco antipiretico ed analgesico, causa in media 200 decessi l’anno in Inghilterra, tanti quanti ne provoca l’uso di tutte le droghe illecite e circa trenta volte più delle morti dovute all’ecstasy nello stesso paese. E rivela, inoltre, che quasi l’1% dei partecipanti alle corse amatoriali di fondo ha bisogno del ricovero ospedaliero durante o dopo la gara. Così, se il motivo per cui i governi proibiscono l’ecstasy e le altre droghe fosse veramente quello di salvaguardare la vita dei cittadini, per coerenza, e a maggior ragione, si dovrebbero rendere illegali le sigarette, il gioco del calcio, le automobili, e addirittura lo starsene a casa.
Abbandoniamo le statistiche e sviluppiamo allora questo paradosso. Se ammettiamo il principio paternalistico per cui lo stato può controllare il comportamento degli individui per proteggerli da se stessi, siamo costretti a chiederci perché tale controllo si limiti soltanto alla sfera fisica. “Non è il male che si può infliggere all’anima e alla mente ancora più disastroso dei mali fisici?”, Si chiedeva l’economista e filosofo Ludwig von Mises nel 1949. E allora perché non impedire di leggere brutti libri, di vedere cattivi spettacoli, di guardare cattivi dipinti, di pensare idee brutte, di ascoltare cattiva musica? “Il male fatto dalle cattive ideologie”, scriveva Von Mises, “è certamente molto più pernicioso sia per l’individuo che per la società intera di quello fatto dalle droghe”.
[1] Nutt, David, Equasy–An overlooked addiction with implications for the current debate on drug harms, Journal of Psychopharmacology, 23(1) (2009) 3–5.