In questo post cercheremo di caratterizzare che cosa sperimenta, dal punto di vista fenomenologico, un soggetto che dipende da una droga quando riferisce di non avere il controllo sull’uso della sostanza e di sentirsi in certo modo costretto ad assumere la sostanza da cui dipende.
Come abbiamo visto in un precedente post, un tossicodipendente sembra compiere le azioni di ricerca e consumo della sostanza in maniera intenzionale e volontaria. Egli sembra cioè comportarsi in modo simile alle altre azioni che appare scegliere o non scegliere, ad esempio accendere la televisione, prepararsi e bere un tè, comprare un giornale e così via.
D’altra parte, l’impossibilità del soggetto di agire diversamente è comunemente ritenuta un tratto definitorio della dipendenza. Un soggetto dipendente sembrerebbe cioè costretto ad assumere la sostanza anche se non lo volesse o contro la sua stessa volontà, o meglio contro intenzioni assunte come impegno, come accade nei tentativi fallimentari di cercare di interrompere il consumo e nelle ricadute. La condizione riferita dalle persone che soffrono una condizione di dipendenza lascia così pensare che esse siano nell’impossibilità di agire diversamente, costrette a reiterare un comportamento che hanno l’intenzione di interrompere. Questo conflitto tra aspirazioni ideali e comportamenti reiterati suggerirebbe di escludere la possibilità di considerare le sue azioni pienamente libere e volontarie in senso pieno, sebbene esse siano intenzionali in senso minimo, malgrado cioè il fatto che i comportamenti di ricerca e consumo di una sostanza si realizzino con decisioni e sequenze di azioni strumentali in un processo analogo a quello degli altri comportamenti intenzionali che giudichiamo liberi.
Questa tensione tra azioni intenzionali e volontà non libera è riflettuta direttamente dai racconti dei soggetti dipendenti che chiedono aiuto e iniziano un percorso di recupero. La ragione principale che li spinge a cercare aiuto è difatti precisamente l’idea di vivere un’esperienza di costrizione. Sentono appunto che non sono in grado di agire diversamente, sebbene possano senz’altro affermare o riconoscere che quando desiderano la sostanza pianifichino intenzionalmente il modo per procurarsela e consumarla. Essi stessi, insomma, avvertono con chiarezza che questo tipo di intenzione pianificata non è affatto sufficiente per avere volontà libera e che questa volontà libera è esattamente ciò che nella dipendenza hanno perduto.
Il concetto di akrasìa
Per comprendere la fenomenologia della costrizione di cui parlano i dipendenti stessi è utile rifarsi a un cruciale concetto aristotelico che descrive un fenomeno di grande interesse, non a caso ripreso ampiamente nella riflessione filosofica sull’azione e la volontà. Si tratta del fenomeno dell’akrasìa, parola che viene generalmente tradotta in italiano con il termine “incontinenza”, oppure, in traduzione meno diretta e più libera, con l’espressione di “debolezza della volontà”[1]. Ne abbiamo parlato più in generale anche in un altro post.
L’akrasia è anche descritta come la condizione in cui si agisce contro il proprio miglior interesse o vista come una mancanza o un fallimento dell’autocontrollo. Ed è tipicamente una condizione che purtroppo determina il sabotaggio di buona parte delle decisioni in cui le gratificazioni a lungo termine finiscono per soccombere di fronte a ricompense a breve termine, cui pur assegniamo a mente fredda un valore minore: il terzo hamburger con patatine contro l’aspirazione alla forma fisica e alla salute, l’ennesima ora su Facebook contro il completamento della tesi di laurea o di un importante documento di lavoro, il bicchiere di alcol a dispetto del pericolo di ricaduta e contro il benessere psicofisico che un alcolista in riabilitazione riconosce all’astinenza .

Una condizione che ha trovato molte penetranti espressioni letterarie. Nella Lettera ai Romani, ad esempio, San Paolo scrive: “Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c’è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.[2]” Analogamente, nella Metamorfosi, Ovidio fa dire a Medea: “Vedo il meglio e l’approvo, ma seguo il peggio”[3], quando questa decide di trasgredire i suoi doveri morali verso la famiglia e la patria per aiutare l’amato Giasone. Una contraddizione che Petrarca esprime allo stesso modo:
“Cerco del viver mio novo consiglio,
e veggio ’l meglio et al peggior m’appiglio”[4].
Nella versione aristotelica classica, l’akrasìa è il fenomeno, psicologico e pratico insieme, che sperimenta colui che “agisce intenzionalmente contro il proprio miglior giudizio”, ed è descritta come una condizione di irrazionalità difficile da trattare e soprattutto da spiegare. La sua irrazionalità consiste nel fatto che, normalmente, un agente compie l’azione che è motivata da ciò che lui stesso giudica la cosa migliore da fare. Sottesa a questa idea è l’assunzione che nessuno che sia davvero razionale fa ciò che pensa sia la cosa peggiore da fare, o quella in ogni caso non ottimale. L’accordo coerente tra ciò che il nostro miglior giudizio ci dice di fare e l’azione che ne consegue è ritenuto un requisito di razionalità irrinunciabile. Tuttavia, come abbiamo in parte esposto sopra, il mondo, la nostra stessa comune esperienza personale, offrono numerosi esempi di azioni che non soddisfano questo requisito. Azioni che vengono messe in atto nonostante il fatto che colui che agisce giudichi che ciò cui si appresta non è la cosa migliore da fare. Si tratta cioè di comportamenti che sono contrari a ciò che il miglior giudizio dell’agente chiaramente suggerisce.
Il caso della dipendenza sembra rappresentare uno dei principali esempi di questa situazione di disaccordo irrazionale tra giudizio e azione in cui un soggetto può venire a trovarsi, sebbene non manchino fenomeni di akrasìa in domini che con la dipendenza non hanno a che fare. Per esempio, le emozioni e i sentimenti sembrano essere un potente fattore di comportamento akratico: nonostante un soggetto giudichi che sia meglio non arrabbiarsi, alla fine si arrabbia; oppure, nonostante un soggetto giudichi che sia meglio non intraprendere il corteggiamento di una certa persona, alla fine questo è precisamente quello che fa.
Per i nostri scopi, tuttavia, concentriamoci sul caso della dipendenza. Quando il soggetto riferisce che è costretto ad assumere la sostanza, è implicito nella costrizione di cui parla il fatto che giudica che la cosa migliore da fare sia l’azione esattamente opposta, ovvero non assumerla. Tuttavia, il suo comportamento non si accorda con il suo miglior giudizio, e quindi se non l’ha se la procura, e poi la usa; oppure se gli viene offerta o se è disponibile, la consuma immediatamente.
Il disaccordo tra il suo miglior giudizio e l’azione che compie è ciò di cui egli soffre, e ciò che lo induce a cercare aiuto, riportando appunto una costrizione, una condizione di volontà amputata e inefficace. A complicare il quadro e la condizione sofferta, il soggetto che patisce la dipendenza non comprende perché si comporta così, dal momento che consapevolmente sente di giudicare di dover agire del tutto diversamente. Questo è un aspetto fondamentale del problema della debolezza della volontà e della perdita del controllo su un comportamento a dispetto della consapevolezza delle sue conseguenze. Il filosofo Donald Davidson ha riflettuto a lungo su questo tema. Secondo Davidson, non comprendere se stessi quando si è akratici, quando cioè si agisce contrariamente al proprio miglior giudizio, è una forma di irrazionalità che appare prima di tutto proprio all’agente stesso, alla persona ne vive e ne percepisce l’inesplicabile contraddittorietà[5].
L’esperienza dell’akrasìa come contraddizione tra ragioni e cause
Se l’akratico per primo non comprende perché si comporta così, anche l’osservatore non ha vita facile a cercare di comprendere, e quindi spiegare, l’akrasìa. Uno dei migliori tentativi di inquadrare la situazione psicologica e pratica in cui l’akrasìa consiste è quello di immaginare la mente dell’akratico come divisa tra due diversi campi di forze. Da una parte ci sono i suoi giudizi, fondati su ragioni normative, cioè ragioni, costrutti razionali che giustificano un certo corso d’azione, che ne misurano il valore e l’impatto personale, e quindi lo consigliano. Dall’altra, ci sono delle forze motivazionali di carattere non normativo e non razionale, in buona parte anche inconsce e non verbalizzabili e cioè impulsi, desideri, appetiti, istinti, che non giustificano una certa azione, proprio in quanto non consapevoli e non razionalizzabili, ma che tuttavia possono avere la forza di indurla, imponendola.
La costrizione di cui parla il dipendente, e che sperimenta dal punto di vista fenomenologico, sarebbe allora dovuta alla potente spinta di queste forze motivazionali di carattere non normativo e non razionale, bensì puramente causale, che non giustificano l’azione akratica (e dunque non la rendono neppure comprensibile al soggetto, che ha invece chiari i suoi migliori giudizi in merito), e tuttavia la causano.
Donald Davidson, quale principale fautore di questa caratterizzazione dell’akrasìa, tracciando la distinzione tra ragioni e cause, offre dunque un inquadramento del fenomeno, e in qualche misura una sua spiegazione. Naturalmente, si tratta di una spiegazione che non ci dice perché questo accada, cioè perché possano arrivare ad esistere cause più forti delle nostre migliori ragioni. Probabilmente la ricerca può indicarci come questo sia possibile, a partire proprio dall’azione di una sostanza sulla costruzione dei comportamenti compulsivi e sull’interferenza che ciò determina a carico delle strutture e dei centri cerebrali che entrano in gioco nei processi decisionali e nel controllo volontario del comportamento.
La distinzione tra cause e ragioni nei comportamenti akratici, nella volontà debole, sembra fermarsi a un livello relativamente superficiale di spiegazione. Ma essa offre di fatto quella che potremmo chiamare una “descrizione esplicativa”, cioè una descrizione che ci aiuta a comprendere quel che sta succedendo nella mente del dipendente, o dell’akratico più in generale, delle persone che cadono nei comportamenti che sanno di essere contrari al loro giudizio e ai loro veri interessi. Per tali ragioni, questa spiegazione può essere utile sia per indirizzare la ricerca, sia per tentare di favorire quella riunificazione coordinata tra ragioni e azioni che nella psicologia di un dipendente drammaticamente manca, così che egli possa finalmente agire sulla base delle sue migliori ragioni, invece di essere in balia della cause che lo sopravanzano. D’altra parte, offrire al dipendente la descrizione esplicativa del suo stato in termini di akrasìa, può aiutarlo a prendere coscienza del regime causale “cieco” al quale è sottoposto, del perché, appunto, si senta, di fatto a ragione, costretto ad agire come agisce, e del perché, sempre a ragione, non avverta queste azioni come davvero sue, libere e autonome: un tipo di consapevolezza che già, in parte, costituisce una cura, o perlomeno l’inizio di un percorso di cura.
Patrizia Pedrini e Stefano Canali
Riferimenti bibliografici
[1] Davidson, D. 1980a. “How is Weakness of the Will Possible?”, in Id., Essays on Actions and Events, 21-42, Oxford: Oxford University Press. Davidson, D. 1980b. “Intending”, in Id., Essays on Actions and Events, 83-102, Oxford: Oxford University Press. Mele, A. R. 2002, “Akrarics and Addicts”, American Philosophical Quarterly, 39, 153-167. Heather, N., & Segal, G., 2015. “Is addiction a myth? Donald Davidson’s solution to the problem of akrasia says not”, International Journal of Alcohol and Drug Research, 4(1), 77-83.
[2] San Paolo, Lettera ai Romani, 7,18-19.
[3] Ovidio, Metamorfosi, Libro VII, in, vv. 20-21.
[4] Petrarca, Canzoniere, CCLXIV, v 136-137
[5] Oltre agli scritti di Davidson citatati, cf. Setiya, K. 2007. Reasons Without Rationalism, Princeton, NJ: Princeton University Press, per i concetto di “clear-eyed akrasìa”, cioè di akrasìa consapevole.
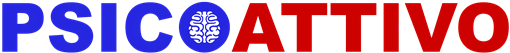
One Comment
Una considerazione al volo sull’akrasia che potrebbe essere la chiave di lettura sull’agito akrasico nella dipendenza è la seguente: quanto è penoso in termine di dolore l’attuazione del “proprio miglior giudizio” che presuppone l’astinenza (dolore ben presente nella neurobiologia dell’addiction sotto forma anche dell’iperkatifeia (Shurman et al. 2010)), e quanto è invece gratificante “cadere nei comportamenti che sanno di essere contrari al loro giudizio e ai loro veri interessi” , in primis per postporre per un certo tempo l’iperkatifeia, ed anche per sperimentare quel piccolo picco di dopamina concesso ad ogni consumo che permette, seguendo il modello di Koob e coll. (addiction as a stress surfeit disorder) un intervallo di funzionamento di “normalità allostatica” che diventa ormai il rinforzo principale per il consumo di droga.